Perché non dobbiamo sottovalutare “Il ritorno della razza”
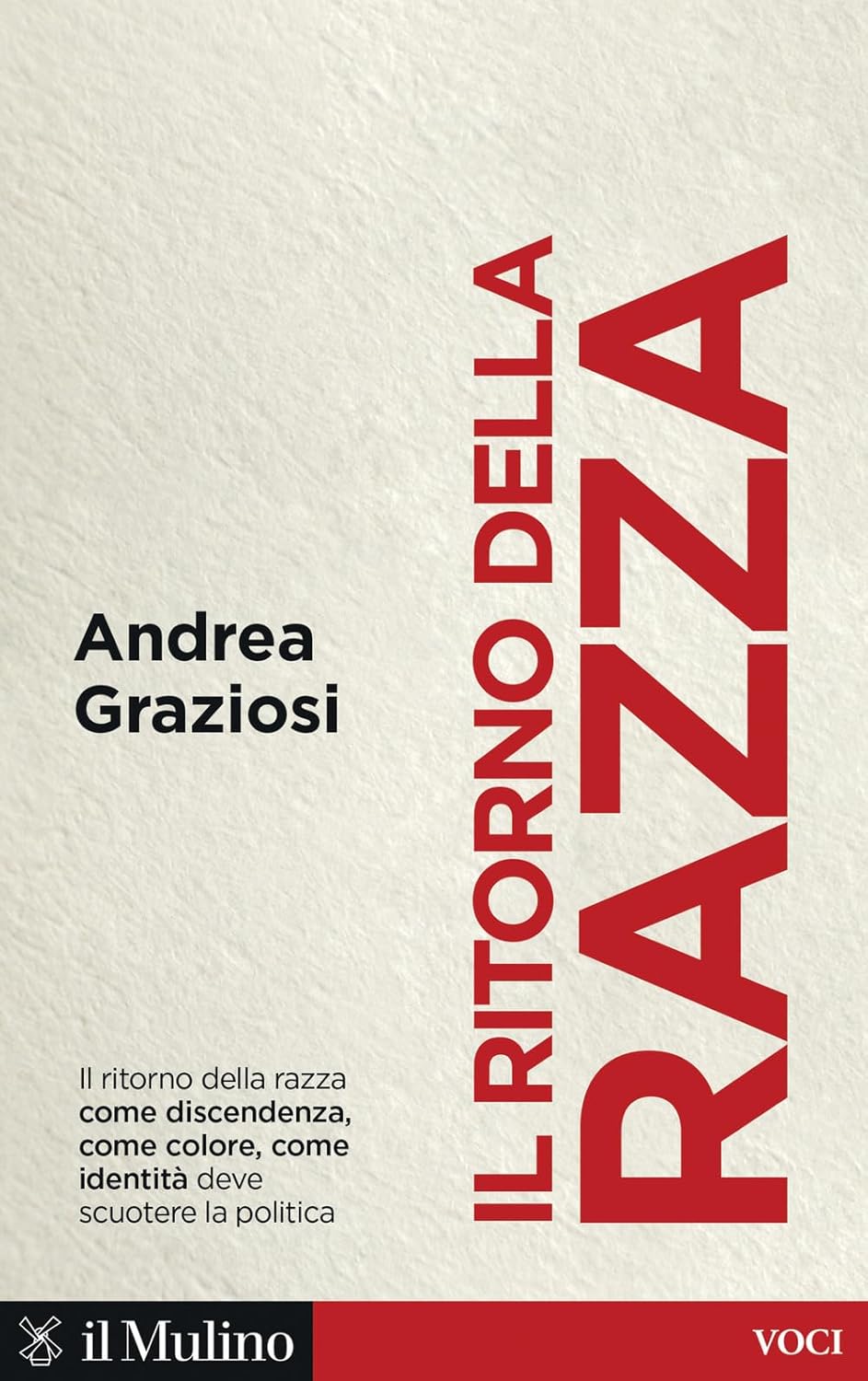
Tra scienza, politica e società, “Il ritorno della razza” di Andrea Graziosi traccia la storia di una categoria che ha segnato il mondo
Titolo: Il ritorno della razza. Le radici di un grande problema politico
Autore: Andrea Graziosi
Casa editrice: il Mulino
Anno: 2025
Pagine: 170
ISBN: 9788815391377
Prezzo: 13€
Presenza ingombrante e difficile da imbrigliare, il concetto di “razza” nella storia delle società occidentali ha acquisito nel tempo diversi significati e diversi sono stati i giudizi di valore su tale nozione. Per il lettore contemporaneo potrebbe essere estraniante, ma il concetto di “razza” non ha sempre ricevuto il giudizio negativo tipico dei nostri giorni e veniva adoperato senza troppe remore fino agli anni Trenta, cioè fino a quando con l’ideologia nazista il riferimento alla razza non ha assunto connotazioni evidentemente pericolose e tragiche.
Andrea Graziosi, professore di storia contemporanea alla Federico II di Napoli, ripercorre ne Il ritorno della razza gli sviluppi di tale concetto per arrivare a comprendere come mai oggi siano ritornati modi di pensare basati su classificazioni di tipo razziale.
Il libro, uscito a gennaio 2025 per il Mulino, è parte di un progetto più grande, presentato da Graziosi come il tentativo di scrivere una storia delle classificazioni umane e delle varie declinazioni dei concetti di uguaglianza e differenza. Le vicende della nozione di razza vengono comprese, dunque, all’interno del più vasto campo delle coordinate umane di interpretazione della realtà; il termine razza rappresenta sotto quest’ottica uno dei dispositivi atti a rendere conto delle diversità e delle somiglianze tra esseri umani e nello specifico attua una classificazione di questi ultimi al di sotto di «categorie collettive basate sulla discendenza e spesso ordinate gerarchicamente» (p. 11). Dato che si esamina l’evoluzione storica del razzismo, il testo non può che focalizzarsi sia sugli usi politici della nozione di razza sia sui rapporti tra questi usi politici e le teorie scientifiche del tempo; e non può che accostare al concetto di razza altre nozioni essenziali per comprendere tale categorizzazione, come quelle di popolo e di nazione.
Razza, popolo e nazione dall’antichità all’età moderna
Il testo non parte dall’analisi del concetto di razza, ma inizia la sua analisi delle categorizzazioni degli umani a partire dall’antichità classica, cioè da uno dei punti di partenza delle nostre culture e società occidentali. Nell’antichità non vi era un vero e proprio concetto di razza e diverse erano le categorie adoperate al fine di classificare i popoli altri e spiegare le diversità tra le popolazioni.
Nell’antica Roma si utilizzavano concetti come quelli di populus, gens ed ethnos. Il populus romano era connotato a livello politico più che secondo un criterio di parentela: si era membri del popolo romano quando si era partecipi del suo diritto “civile”. I termini gens ed ethnos non erano invece adoperati per connotare una comunità abitante di una certa zona geografica, ma designavano un gruppo di famiglie che si riconoscevano unite tra loro da un antenato comune, al quale spesso erano legati racconti mitici e leggende. Nell’antica Grecia, invece, vari autori – tra i quali Graziosi cita in particolare Erodoto – avevano un’idea di comunità vicina al nostro concetto di popolo, i cui membri erano legati assieme «da una comune ascendenza espressa dalla lingua ma anche dal sangue» (pp. 22-23). Nonostante tale concetto di comunità, i Greci consideravano tutta l’umanità accomunata da un’unica essenza, che rendeva uguali tutti gli esseri umani. Gli elementi caratterizzanti questa unica essenza umana comune erano spesso il possesso della ragione e l’uso del linguaggio. Tali tesi universalistiche, però, non devono far pensare che nel mondo classico mancassero dichiarazioni di superiorità del proprio gruppo di appartenenza o fenomeni di odio e violenza verso altre popolazioni – che in alcuni casi hanno portato a veri e propri stermini.
Alla fine dell’età antica, ulteriori istanze universalistiche sono state portate avanti dalla Chiesa cattolica. L’enfasi sugli elementi comuni dell’umanità viene però presto sostituita da una nuova enfasi sulle differenze tra gruppi etnici con l’inizio delle invasioni barbariche. Alla nozione politica e romana di popolo si è sostituita, infatti, un concetto di popolazione etnico, che spesso riconosceva l’unità di un singolo popolo per via della comune discendenza da un unico capostipite. A differenza di quel che accade oggi, i popoli non erano connotati a livello regionale ma, all’interno di una stessa comunità, potevano coesistere diversi gruppi che si definivano come tali. La divisione tra popoli all’interno di una stessa comunità rifletteva spesso le differenze di classe: l’appartenenza etnica era stata prima utilizzata come strumento di divisione tra la nobilità armata germanica e la più numerosa popolazione locale; in seguito, dall’anno Mille in poi, è stata utilizzata come spartiacque tra nobili “gentili” e servi “nativi”. La diversità etnica, come si può ben intuire, era funzionale a giustificare i privilegi nobiliari e proprio a partire da questa legittimazione del dominio nobiliare si inizia ad adoperare il termine “razza” (inizialmente diffusosi in Italia, come sottolineato dal linguista Lino Leonardi nel suo libro Razza, era probabilmente nato dal calco del termine francese haraz, impiegato per designare le razze dei cavalli).
In età moderna l’esclusività dell’utilizzo da parte delle classi nobili della diversità etnica e del termine razza per mantenere il proprio dominio viene messa in crisi da tre grandi fratture. La prima di esse riguarda le leggi spagnole, entrate in vigore a partire dal 1449, sulla limpieza de sangre. A seguito della Reconquista spagnola e della massiccia conversione al cristianesimo della popolazione sconfitta, tale legge sanciva che per mantenere determinate cariche e privilegi nobiliari bisognasse non solo convertirsi al cattolicesimo, ma dare prova di discendenti cristiani. Il decreto aveva lo scopo di impedire conversioni da parte dei nobili sconfitti con il solo scopo di mantenere il proprio status sociale, ma ha inaugurato contestualmente una lunga e violenta stagione di ricerca di una presunta purezza etno-religiosa in Europa. La seconda grande frattura riguarda la scoperta delle Americhe, che portò per la prima volta gli europei di fronte a popolazioni completamente estranee e al conseguente dibattito sulla natura, più o meno umana, degli abitanti del nuovo continente. Ricordiamo le riflessioni del teologo Bartolomé de Las Casas, che affermava l’uguaglianza tra esseri umani ma che al contempo postulava diversi stadi di sviluppo dell’umanità, o l’umanista Juan Ginés de Sepúlveda, che vedeva negli indigeni americani l’esemplificazione degli “schiavi naturali” di Aristotele. La terza e ultima frattura riguarda la Riforma protestante. La Riforma non solo preparava – seppure in parallelo a istanze di tolleranza religiosa – il terreno a un futuro razzismo “separatista”, ma esponeva anche i nobili a violenze e guerre spietate nate dalle divergenze di confessione.
Da queste fratture appare evidente come il riscorso a criteri etnici o a discorsi sulla discendenza non era più appannaggio del discorso nobiliare; e i nobili e i loro privilegi non erano più difesi da una presunta superiorità di sangue. Il termine razza, però, non scompare e inizia invece ad assumere i connotati che oggi conosciamo.
La prima vera immagine di un’umanità divisa in razze distinte e ben determinate si ha con il testo di François Bernier del 1684, Nouvelle division de la terre par le différentes espèces d’hommes qui l’habitent. La gerarchizzazione – cioè la disposizione delle classi lungo una scala di maggiore o minore perfezione – di questi nuovi gruppi umani, le razze, si ha con Henri de Boulainvilliers e la sua visione della storia come conflitto tra popoli. All’emergere di queste nuove classificazioni razziali, si accompagnò presto la tesi del plurigenismo: per tale tesi gli esseri umani non avrebbero un’origine comune, una comune discendenza, ma sarebbero discendenti di gruppi umani differenti e separati. Con una ricostruzione puntuale di storia della scienza, Graziosi inquadra il plurigenismo come un tentativo di indagare la natura umana andando oltre i dogmi delle Sacre Scritture, senza però aver prima sviluppato quelle conoscenze scientifiche indispensabili per comprenderla: non mancherebbe solo la cornice dell’evoluzionismo darwiniano, ma anche la reale contezza dell’età della Terra, che veniva al tempo calcolata non oltre qualche migliaio di anni.
In età moderna va modificandosi anche la nozione di popolo, che si avvicina a quella odierna. Identificato con la nazionalità, il popolo acquisiva connotazioni molto diverse dal popolo romano o dalla nobiltà barbara e veniva concepito come una realtà autonoma con caratteristiche etniche precise e i cui membri erano abitanti di zone geografiche con confini precisi: i popoli erano ormai, a detta di Graziosi, «“superindividui” gerarchizzabili dotati di vita e qualità proprie e ritenuti superiori ai singoli esseri umani» (pp. 60-61). Da questa visione del popolo si baserà poi il razzismo gerarchizzante europeo. Tra le varie connotazioni di questo nuovo concetto, possiamo annoverare l’idea di popolo come volgo contadino. Sulla scia dell’esaltazione del volgo emerge l’idea del Geist des Volkes (lo spirito dei popoli) del filologo tedesco Johann Herder, che avrà molta influenza nel ’900. Attraverso un appello alla purezza e alla semplicità del popolo contadino tedesco contro il cosmopolitismo francese, le riflessioni herderiane pongono per la prima volta le fondamenta delle nazioni e degli stati su altrettanti fantomatici spiriti dei popoli. Anche in Italia assistiamo a uno sviluppo delle idee herderiane, soprattutto con il sogno mazziniano di confini che potessero contenere tutto un popolo e soltanto un popolo: ideale che presto diventerà un incubo.
Da questo concetto di popolo, con marcate caratteristiche etniche e bisognoso di confini geografici ben precisi, discendono le tragiche conseguenze del razzismo europeo.
Razzismo scientifico e antirazzismo darwiniano
Durante la trasformazione del concetto di popolo in popolo-nazione, anche i vari percorsi scientifici del tempo si confrontano con un mondo che appare sempre più abitato da diversità umane. Lo studio di questa diversità interessava soprattutto le scienze naturali e la nascente linguistica.
Nello studio delle razze – che oggi sappiamo esser state solo presunte – agli inizi dell’Ottocento si vide l’emergere di una nuova disciplina, la frenologia, che acquisì nel corso del secolo sempre più successo fino a un rapido declino a seguito della perdita di credibilità delle sue premesse empiriche. Nata dagli studi sui crani di Franz Joseph Gall, la frenologia ipotizzava che carattere e capacità intellettuali di una persona fossero direttamente collegate alla conformazione del cranio, a sua volta collegata a quella del cervello. Presto si passò allo studio delle differenze del cranio delle varie popolazioni umane, ponendo queste ultime in una scala gerarchica. Basata su vari errori oggi ampiamente riconosciuti come tali, la frenologia ha assunto nell’ ’800 la funzione di legittimare la presunta superiorità intellettuale europea e i vari pregiudizi verso i popoli degli altri continenti. Sempre nel campo degli studi naturalistici era ancora in voga la poligenesi come spiegazione delle diversità delle popolazioni umane e aveva come suoi sostenitori scienziati del calibro di Broca e Virchow.
Nelle scienze naturali non erano presenti, però, solo impostazioni di stampo razzista e che separavano l’umanità in gruppi etnici dai confini ben precisi: una delle teorie più importanti di impostazione non-razzista è sicuramente quella darwiniana. Non solo Darwin ribadì con chiarezza la monogenesi della specie umana, ma la sua teoria della discendenza con modificazioni, presupponendo la variazione come agente a tutti i livelli e il cambiamento come vero motore dell’evoluzione, minava anche le basi di un qualsiasi discorso che poneva la conservazione delle differenze tra gruppi come una realtà stabile e non modificabile. Sottolineando la variazione a tutti i livelli e non negando la differenza ma accentuando quella tra individui, la teoria darwiniana almeno a livello teorico smontava la visione razzista riguardo la specie umana e minava alla base l’idea dei popoli come entità super-individuali con confini precisi e caratteristiche stabili.
Nonostante l’impostazione darwiniana screditasse la razza e la fissità dei caratteri, il discorso evoluzionistico venne ben presto cooptato per avvalorare la visione razziale. Sotto il termine ombrello del darwinismo sociale – che, come abbiamo visto in altri articoli, è un insieme di teorie molto poco omogeneo – molte teorie hanno pensato l’evoluzione come una conferma della superiorità europea. Non potendo negare la monogenesi e non negando l’uguaglianza di fatto degli esseri umani, tali autori, scrive Graziosi, si facevano portavoce di un “razzismo cosmopolita”, che negava pari dignità e sviluppo ai popoli non europei.
Nel campo di studi della linguistica, invece, si rigettavano i risultati della craniometria e della frenologia e si poneva l’analisi della lingua come campo di studio delle discendenze e delle diversità umane. Neanche in questa disciplina, però, mancavano impostazioni di stampo razziale: con l’identificazione tra lingue e popoli/razze e ponendo le lingue/razze europee ed ariane al di sopra delle altre, infatti, anche nella linguistica ottocentesca (con eccezioni come Franz Bopp e Max Müller) si era ormai diffusa quella visione razzista ormai presente in tutta Europa.
A livello politico, la visione razziale ottocentesca trova un’ulteriore stabilizzazione con il testo di Joseph Arthur de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines. Oltre all’impiego in maniera indifferente dei termini razza, nazione e popolo, la tesi principale del testo sosteneva che la vittoria tedesca sulla Francia dipendesse da un fattore etnico: il popolo tedesco avrebbe vinto perché rimasto puro e quindi stabile, mentre la nazione francese, contaminandosi con varie etnie, si sarebbe disunita sul piano nazionale e quindi indebolita sul piano militare. Seppur de Gobineau fosse antinazionalista e non sposasse tesi apertamente razziste e nonostante le sue teorie fossero delegittimate dalla più solida teoria darwiniana, in un Europa, in cui si era ormai diffuso dappertutto il virus del concetto di razza, il testo fu preso come modello argomentativo per il razzismo e l’antisemitismo europei fino al XX secolo.
Come possiamo vedere dalla ricostruzione di Graziosi, il rapporto tra scienza e politica risulta altamente complesso, con un’influenza non solo vicendevole ma spesso poco lineare e difficile da ricostruire. Questo problema, definibile come il problema del rapporto tra scienza e società, è una questione tipica della sociologia e della filosofia della scienza. Più che imputare a una generica scienza la nascita di tesi razziste, come magari i non addetti ai lavori possono pensare, vediamo grazie a questo testo che ancor prima di una giustificazione da parte di una disciplina empirica le teorie razziste venivano esposte nell’arena politica e utilizzate come strumento di legittimazione; inoltre non tutta la scienza del periodo era schierata a favore di una categorizzazione razziale, come possiamo vedere nel caso del darwinismo. I testi come Il ritorno della razza mostrano quindi come l’indagine storica possa portate un aiuto indispensabile nello studio di dinamiche complesse come quelle tra scienza e società, che difficilmente sono descrivibili attraverso un singolo schema generale.
Razza e colore dal XX secolo ai giorni nostri
Nel Novecento, quindi, il dibattitto scientifico e politico eredita dall’ Ottocento un contesto in cui il termine razza era utilizzato senza troppe remore ed era spesso considerato sinonimo dei termini popolo e nazione. La linguistica e le scienze naturali, con importanti eccezioni, pullulavano di tesi che concepivano differenze stabili e nette tra vari gruppi umani, adoperando spesso il termine razza. A livello politico, avevano molta influenza le teorie herderiane e le teorie di de Gobineau. Anche fuori Europa in alcuni contesti viene ripreso il concetto di razza europeo legato al concetto herderiano di popolo, come nel caso di José Vasconcelos in Messico. Dove però la visione razzista mostra tutta la sua pericolosità, è ovviamente in Germania con il nazionalsocialismo.
Come risposta alla brutalità di questa ideologia, inizia il tabù del termine, incentivato anche dal lavoro di divulgazione di alcuni esponenti della biologia – al tempo protagonisti della cosiddetta Sintesi Moderna – che ribadivano al grande pubblico l’unicità della specie umana e l’assenza di razze biologiche nella nostra specie. Da questo tabù del razzismo abbiamo gli ultimi snodi che portano all’attuale situazione.
Più che eliminare qualsiasi riferimento a razza o classificazioni etniche interne all’umanità, il tabù ha colpito prevalentemente il razzismo scientifico e quello più largamente europeo. Al contempo, però, nel dopoguerra resisteva ancora tenacemente l’idea di popolo di stampo herderiano e si vide l’emergenza, nei discorsi soprattutto prodotti in spazi extra-europei, del riferimento – come scrive Graziosi – al “colore”.
Esempi di rifacimento alla nozione herderiana di popolo si hanno in intellettuali come Jan Smuts, ma anche nella Dichiarazione Unesco sulla razza e i pregiudizi razziali del 1967. Negli anni Cinquanta, nel contesto delle lotte anticoloniali e degli studi decoloniali si vide, a detta di Graziosi, un riemergere della nozione di razza nella solidarietà basata sull’essere neri e africani e nell’esaltazione della Négritude. Negli Stati Uniti degli anni Cinquanta, invece, mentre i censimenti erano redatti ancora secondo criteri razziali, iniziavano le lotte contro la segregazione razziale. Dato questo contesto, negli USA emerse il problema di quali principi dovessero guidare le proteste: l’universalismo e le rivendicazioni di uguaglianza o «un’affermazione di differenza e di uguale dignità della differenza» (p. 140)? Alla fine, a esser più popolare fu il secondo tipo di approccio, per cui «in nome della lotta al razzismo si decise di usare lo strumento della razza» (p. 135). Secondo Graziosi, ciò ha rappresentato una vera e propria rivoluzione politica, poiché rovesciava il discorso razzista, non solo perché preso e rifunzionalizzato da chi era stato discriminato dal pensiero e dalle politiche europee, ma anche perché il concetto di razza fu «consacrato e l’appartenenza di razza resa desiderabile» (p. 138). Come risultato si ebbe l’erosione del concetto di cittadinanza universale per una «differenza, il cui riconoscimento e la cui difesa accendevano interessi, coagulavano gruppi di pressione e dividevano una società i cui singoli individui perdevano almeno parte della loro indipendenza» (p. 140). Per Graziosi, però, anche se l’intento di questi movimenti era l’emancipazione di individui e gruppi sociali oppressi, questo nuovo rifacimento alla razza non era meno fallace e meno pericoloso.
Anche negli ambienti di destra e meno tolleranti verso il generico Altro, il tabù della razza e la resistenza del concetto di popolo herderiano portarono a una ridefinizione teorica: in contrasto con internazionalismo e cosmopolitismo, la destra intercettò l’esaltazione delle culture e della diversità in una prospettiva particolare, celebrando le differenze ma al contempo inseguendo l’ideale che ogni popolo dovesse restare “a casa propria”. Alla celebrazione delle proprie radici e della propria identità si accompagna spesso tuttora un’ostilità molto aperta all’immigrazione: seppur imbellettata con generiche dichiarazioni contro il razzismo, questo tipo di destra radicale non esita a utilizzare immagini tipiche del precedente passato razzista europeo e a usare toni poco civili e violenti verso il fenomeno migratorio.
Conclusioni
Il ritorno della razza ci presenta una breve e agile storia del concetto di razza e dell’evoluzione del razzismo in Europa. Mostra come tale storia sia molto complessa e intricata e come sia necessario prendere in esami diversi elementi e guardare alle varie radici del problema. Tra scienza, politica e dinamiche sociali il testo è testimonianza di come l’approccio storico ci aiuti a tenere uno sguardo pluralista su fenomeno tanto complesso. La ricostruzione delle vicende del concetto di razza ha per Graziosi anche un importante valore politico, poiché ci mostra che le categorie e i modi di pensiero di impostazione razziale siano ancora tra noi nonostante il tabù del termine. Graziosi sembra nel testo criticare anche alcune voci del pensiero post- e decoloniale, che avrebbero – persino loro–, seppur in senso alla lotta al razzismo, irrigidito troppo le differenze tra i vari gruppi etnici.
Legato a quest’ultimo punto, vorrei aggiungere alle tesi di Graziosi un breve approfondimento su post- e decolonialismo. Seppur in ampi movimenti come quelli postcoloniali risulta quasi inevitabile l’occorrenza di posizioni poco accorte circa il tema della razza e delle diversità umane, e seppure il caso di Vasconcelos mostri la ripresa di categorie razziali europee in ambienti fuori l’Occidente classico, credo sia utile sottolineare come le riflessioni post- e decoloniali siano proficui terreni entro cui pensare le tematiche legate al razzismo. D’altronde, con decoloniale e postcoloniale definiamo pratiche e analisi politiche che riflettono sul sistema di potere proprio del colonialismo e cercano anche forme di organizzazione sociale emancipatorie questo sistema di dominio. Nelle analisi che ho potuto approfondire, la razza è considerata non come una realtà biologica o una realtà superindividuale e dai confini netti, ma come una categoria essenziale di un’ideologia legittimante i processi di dominio e sfruttamento propri del potere coloniale.
La razza sarebbe quindi una realtà sociale creata dal sistema coloniale – che nelle letture post- e decoloniali sopravvive ancora in altre forme –, che lo utilizza per legittimare discriminazione e sfruttamento verso determinati gruppi o fasce della popolazione, ed esiste solo quindi all’interno della creazione di gerarchie poste in atto da questo sistema. In questo senso, non esiste una razza come entità astorica; al contempo, però, appare ovvio come non basti semplicemente decidere di non utilizzare termini o categorie razziste per risolvere il problema e dipanare le differenze create dal sistema coloniale e le sue gerarchie. Non va dimenticato quindi che il sistema di potere coloniale condiziona la vita e gli spazi degli individui “razzializzati” attraverso l’esclusione e la discriminazione. Anche i saperi, le culture e le abitudini delle popolazioni razzializzati subiscono tale sistema di potere e possono venire invisibilizzate, ridicolizzate o cooptate. Gli individui delle popolazioni africane vivono determinate esperienze sociali discriminanti anche per via del colore della pelle e hanno tutto l’interesse e il diritto di rivendicare le proprie culture denigrate dal suprematismo europeo. Per dirla in modo semplice, per il pensiero decoloniale non esistono razze, ma esistono le differenze create dall’ideologia razzista. Per questo è necessario, per il pensiero e le pratiche decoloniali, continuare a parlare di differenze all’interno della società rispetto al colore della pelle e alle proprie origini: non perché si creda alla realtà delle razze o a divisioni etniche nette, ma per ricordare la presenza ancora oggi del razzismo e del sistema di potere coloniale.
Ho conseguito la laurea triennale in filosofia presso la Federico II di Napoli nel 2019 e nel 2022 ho
conseguito la laurea magistrale in scienze filosofiche presso L’università Statale di Milano con una
tesi su alcuni risvolti filosofici della teoria di Darwin. Le aree di maggiore interesse per me sono gli
studi su Darwin e la filosofia della biologia, soprattutto rispetto ai temi di filosofia della scienza. Al
momento sono borsista per un progetto di collaborazione editoriale e di ufficio stampa presso
l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici.



