Storia minima d’Europa”: il passato e il presente di un continente senza confini fissi
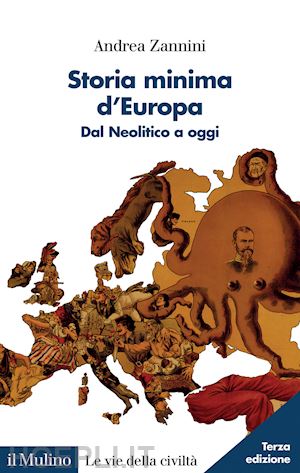
Un racconto storico che ripercorre le radici, le evoluzioni e le contraddizioni dell’Europa, tra continuità e cambiamenti.
Titolo: Storia minima d’Europa. Dal Neolitico a oggi
Autore: Andrea Zannini
Editore: Il Mulino Bologna
Anno: 2025 (3° edizione, 1° 2015, 2° 2019)
Pag.: 367
Dalle nostre parti e da millenni, in vario modo. Vi è poco accordo tra gli studiosi sull’etimologia della parola ‘Europa‘; non meno labirintico appare lo sviluppo della nozione geografica (pur con qualche basilare riferimento fisico); il concetto appare eminentemente storico ovvero comprensibile solo in quanto si modifica con il tempo, ha da tempo a sud il Mediterraneo, l’Atlantico a ovest, l’Artico a nord e comprende a est un territorio fin oltre gli Urali e fin oltre Creta. Il meccanismo che ha maggiormente contribuito alla sua formazione è la contrapposizione etnografica. L’idea di un gruppo di ecosistemi e popoli con caratteristiche comuni si fa strada a partire quasi dall’inizio del Medioevo, sia il mondo greco che quello romano erano imperi mediterranei piuttosto che europei.
Certo, un’Europa originaria, autentica e pura non è mai esistita: lo spazio europeo è sempre stato un luogo di ibridazioni, interazioni, contrasti. D’altronde non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando come non esistano confini fisici a delimitarlo. La storia delle radici prime dell’Europa è un complesso intreccio di lente trasformazioni interne e di veloci fughe in avanti, di impercettibili modificazioni strutturali e di catastrofi improvvise (più o meno “naturali”). Se si cerca di ricostruire e narrare un compendio di fatti e di idee di ogni tipo (politico, religioso, militare, pacifico, serio, romantico, vicino, lontano, tragico, comico, significativo o irrilevante) si corre il rischio di far diventare la storia europea “tutto quello che gli storici vogliono che sia” (Alan John Percival Taylor, 1986). Gli storici (come lui, 1906 – 1990), o i dirigenti politici o i rappresentanti istituzionali, possono correrlo, si sa, tuttavia soprattutto gli storici possono forse contribuire anche a ridurre confusione e ideologie.
L’esperto efficace storico Andrea Zannini (Mestre, 1961) tiene da una ventina d’anni un corso di Storia dell’Europa all’università di Udine. Quando cominciò la costruzione dell’unità europea sembrava procedere a vele spiegate, tra la necessità di numerosi paesi usciti dall’esperienza del blocco sovietico di ancorarsi a un multiforme progetto di democrazia liberale e lo spettro del fondamentalismo religioso jihadista materializzatosi nell’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001. Da allora molto è cambiato, dentro e fuori i paesi dell’Unione, ancor di più sta cambiando negli ultimi anni e in questo 2025. Siamo alla terza aggiornata e integrata edizione del volume uscito nel 2015.
I capitoli sono venti, il primo approfondisce la storia del concetto, geografico o culturale di Europa, e parte dalle definizioni, innanzitutto quelle di continente (inadeguata a capire bene, da noi e nel pianeta Terra) e di eurocentrismo (ideologizzato solo attraverso una serie di precocità e successi). Il secondo capitolo è dedicato alle radici più remote (dall’Africa, con il Neandertal primo vero “europeo”), alla transizione neolitica (dalla Mezzaluna Fertile, con la lenta innovazione stanziale) e alla decisiva storia linguistica (l’inesausta ricerca dell’indoeuropeo, il caso di Creta) che testimonia la ricchezza e al contempo la diversità interna del percorso storico europeo. I successivi capitoli, con accorta selezione di passaggi, personaggi e fatti storicamente rilevanti, sono abbastanza cronologicamente dedicati a: Il mondo antico (greco e romano); La formazione dell’Europa cristiana; Maometto e Carlomagno; L’Europa dei castelli; L’Europa delle città; L’Europa fuori d’Europa; L’età delle religioni armate; le metamorfosi dello stato; Il miracolo europeo; L’età delle rivoluzioni; L’Europa dei diritti; L’Europa delle nazioni; L’età del progresso; L’Europa nel baratro; Il Nuovo Ordine Europeo; Un’Europa ricca e divisa; La costruzione dell’Europa unita; Le ombre d’Europa (l’ultimo ventennio).
Seguono la bibliografia (sia generale essenziale che distinta per capitolo), l’indice dei nomi e l’indice dei luoghi. Continui e rilevanti i riferimenti alle migrazioni, ovviamente: per esempio lo straordinario mosaico linguistico “è il frutto dell’apertura dell’Europa, sin dalle epoche cosiddette preistoriche, alle migrazioni di popolazioni provenienti da altri continenti”. Segnalo che nel maggio 2017 è stata inaugurata a Bruxelles anche la “casa della storia europea”, situata nel parco Léopold, prevalentemente “limitata” agli ultimi due secoli, attraverso oggetti, installazioni interattive, filmati storici e spazi di riflessione, circa trecento mila visitatori fino a inizio 2025.
Valerio Calzolaio è giornalista e saggista. Già deputato per quattro legislature, dal 1996 al 2001 è stato sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, rappresentando il governo italiano ai principali appuntamenti ambientali internazionali (da Kyoto a l’Aja, da Nairobi a New York). Ha svolto per anni attività di consulente Onu per il segretariato della Convenzione per la lotta alla siccità e alla desertificazione. È stato professore a contratto di Diritto Costituzionale all’Università di Macerata. Ha pubblicato, con Telmo Pievani, Libertà di migrare (Einaudi, 2016), i suoi libri più recenti sono La specie meticcia (People, 2019), Migrazioni (Doppiavoce, 2019) e Isole carcere (Edizioni Gruppo Abele), 2022.



